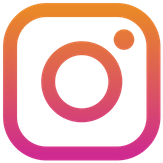CHI SIAMO
CHI SIAMO
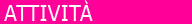 ATTIVITA'
ATTIVITA'
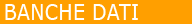 BANCHE DATI
BANCHE DATI
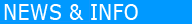 NEWS & INFO
NEWS & INFO
- CIDIM
- Soci
- Musica in rete
- Vincitori di concorsi
- Selezioni e audizioni
- Prime assolute
- Dal vivo in Italia
- Dal vivo nel mondo
- Convegni / Incontri
- Festival e stagioni concertistiche in Italia
- Radio e televisione
- Nuove incisioni, DVD
- Libri e partiture
- Periodici
- Corsi
- Concorsi
- Formazione di base e di nuovo pubblico
- Comunicati e
Rassegna stampa - In Italia e dal mondo
- Festival e stagioni concertistiche nel mondo
 COMMUNITY
COMMUNITY
INTERVISTE
La musica salvata - Conversazione con Roberto Tombesi per i quarant'anni di attività del gruppo vocale strumentale «Calicanto»
C'è qualche episodio, qualche ricordo familiare o qualche incontro a cui si possa far risalire la tua passione per la musica tradizionale? Certamente. Sono nato a Padova, ma i miei genitori erano originari della zona di Jesi, nelle Marche, ed erano entrambi musicisti popolari: mio padre suonava in banda e mia madre cantava. Mio nonno, poi, suonava l'organetto, un parente più antico della fisarmonica i cui maggiori costruttori si trovavano proprio in quella zona. È a questo strumento e alla sua tecnica particolare, diversa da quella della fisarmonica, che mi sono rivolto quando intorno ai vent'anni ho deciso di occuparmi di musica tradizionale. Ed è successo in un periodo in cui la sopravvivenza di questo strumento, come di molti altri, era messa a repentaglio dal cambiamento antropologico legato al boom economico e alla fine della tradizione contadina. Quella dell'organetto è una delle tradizioni che ho contribuito a raccogliere e a divulgare, fino a pubblicare con Riccardo Tesi il primo manuale di tecnica che gli sia mai stato dedicato: L'organetto diatonico (ed. Berbèn 1993). Com'era vissuta la musica tradizionale nel periodo in cui hai iniziato ad occupartene, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta? Erano anni in cui la musica della tradizione era praticamente stata messa al bando, a causa dei cambiamenti sociali legati al miracolo economico e anche per effetto della musica completamente nuova che continuava ad arrivare dall'Inghilterra e dall'America. E insieme alla musica cadevano nell'oblio anche i balli ai quali si accompagnava e gli strumenti di cui faceva uso (la cornamusa, la zampogna, la mandola, il mandolino...). Un patrimonio di sapere trasmesso oralmente che abbiamo contribuito a salvare, e anche a rinnovare mettendolo in dialogo con il mondo contemporaneo. Fin dall'inizio il lavoro di Calicanto è partito dall'indagine sul campo. Com'era fare ricerca etnomusicologica nel Veneto degli anni Settanta e Ottanta? Cercavamo principalmente di incontrare gli anziani che avevano vissuto la tradizione contadina e che potevano testimoniare come fosse il mondo fra le due guerre, o anche prima della Grande Guerra – persone che all'epoca avevano già ottanta o novant'anni. Le intervistavamo e registravamo i canti e le musiche di cui si ricordavano, all'inizio anche con mezzi di fortuna. Nessuno di loro, naturalmente, era musicista professionista: la musica tradizionale era una forma di sapere che veniva insegnata direttamente dai vecchi ai giovani, tutte persone che normalmente facevano altro di lavoro, e legata ad occasioni ben precise come le feste e i balli della vita contadina. Feste e balli che avete contribuito a far rivivere, insieme alla musica tradizionale. È vero! Chi si sarebbe immaginato che la musica tradizionale, che all'epoca sembrava destinata a diventare un oggetto da museo, avrebbe trovato un nuovo pubblico e una nuova fruizione a distanza di decenni? Eppure oggi ci sono giovani, persone di vent'anni o trent'anni, che si trovano e ballano le quadriglie, le mazurke, altre danze tradizionali per puro divertimento e senza annettervi particolari interessi culturali. E il movimento «neo trad» è un fenomeno che non riguarda solo l'Italia. E infatti la tradizione musicale locale può trovarsi in competizione con altre «musiche tradizionali» alloctone: penso per esempio alla musica irlandese... (Ride). Anch'io, dopo degli inizi blues, avevo cominciato a suonare musica irlandese, anzi penso di essere stato uno dei primi a suonarla in Veneto dopo alcuni viaggi in Irlanda durante i quali mi ero innamorato del Paese e dei suoi strumenti. In seguito però ho preferito non fare l'«imitatore» e ho scelto di dedicarmi a un genere di nicchia, ma più originale, legato alle mie radici e che potessi sentire come mio. È così che è nato Calicanto, e a distanza di quarant'anni direi che l'esperimento ha funzionato! Ci sono ancora le condizioni per proseguire la ricerca musicale sul campo in Veneto? Sicuramente non con le stesse modalità di allora. Gli informatori, le persone che potevano ricordare le musiche della tradizione contadina, ormai sono pochissimi o nessuno, quindi il sistema delle interviste e delle registrazioni non ha più senso. Però sono sempre possibili le sorprese, come quella che ci è capitata qualche anno fa con la scoperta di un manoscritto di antiche danze di area cadorina finiti nel New Jersey al tempo dell'emigrazione: balli collettivi (quadriglie, monferrine, manfrine...), di carattere molto diverso da quelli di coppia e quindi molto interessanti anche dal punto di vista antropologico, che abbiamo avuto l'opportunità di trascrivere e di far rivivere nei luoghi originari. La nuova frontiera nella ricerca etnomusicologica è proprio la ricerca negli archivi oppure, nel caso del Veneto, il confronto con le comunità emigrate, presso le quali a volte, per motivi identitari, la tradizione si è conservata più a lungo che in patria. Come si svolgeranno i festeggiamenti per i 40 anni di Calicanto? Inizieremo a celebrare questo anniversario con i concerti che si terranno il 3 e il 4 Settembre 2020 a Padova, al Castello Carrarese. Abbiamo poi in programma molte iniziative diverse, alcune delle quali andranno forse riviste secondo l'andamento dell'attuale emergenza: repliche di spettacoli risalenti a varie fasi della nostra storia, la pubblicazione di un libro fotografico, alcune registrazioni, una mostra con tutti gli strumenti musicali che abbiamo raccolto negli anni e che sono conservati nella nostra sede sociale... Il tutto si chiuderà nell'autunno 2021 con un altro grande concerto, sempre a Padova, durante il quale avremo di nuovo con noi alcuni dei musicisti con cui abbiamo collaborato nel corso di tutti questi anni di storia del gruppo. Leonardo Mezzalira © Cidim 25 agosto 2020 |