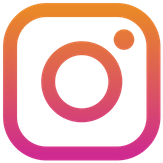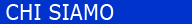 CHI SIAMO
CHI SIAMO
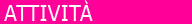 ATTIVITA'
ATTIVITA'
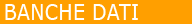 BANCHE DATI
BANCHE DATI
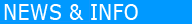 NEWS & INFO
NEWS & INFO
- CIDIM
- Soci
- Musica in rete
- Vincitori di concorsi
- Selezioni e audizioni
- Prime assolute
- Dal vivo in Italia
- Dal vivo nel mondo
- Convegni / Incontri
- Festival e stagioni concertistiche in Italia
- Radio e televisione
- Nuove incisioni, DVD
- Libri e partiture
- Periodici
- Corsi
- Concorsi
- Formazione di base e di nuovo pubblico
- Comunicati e
Rassegna stampa - In Italia e dal mondo
- Festival e stagioni concertistiche nel mondo
 COMMUNITY
COMMUNITY
INTERVISTE
Intervista a Dinko Fabris
In questa intervista risponde alle domande di Fiorella Sassanelli. Pensa che si tratti anche di un riconoscimento al valore della musicologia italiana nel mondo? Tanti italiani nell’ultimo mezzo secolo avrebbero meritato di essere presidenti dell’associazione che raggruppa i musicologi di tutto il mondo: penso per primo a Nino Pirrotta, poi alla generazione che negli anni ’80 del Novecento ha fatto conoscere al mondo la via italiana alla musicologia e in particolare a Pierluigi Petrobelli, che prima di me è stato per due quinquenni rappresentante italiano nel Directorium IMS ed ha ottenuto nel 2009 la rara nomina a membro onorario. Probabilmente la scelta del mio nome è stata associata alla proposta di organizzare a Roma il prossimo convegno della Società, per la quale ho lavorato fin dal 2008 con l’appoggio dello stesso Petrobelli, di Philippe Gossett, Agostino Ziino e Annalisa Bini, oltre che di tanti altri. E infatti dal 1° al 7 luglio 2012 Roma ospiterà il convegno che ogni cinque anni l’IMS tiene in una città del mondo, questa volta dedicato al tema “Musiche, Culture, identità”. Ci può spiegare meglio questo titolo? Questa importante proposta è stata formulata da Fabrizio Della Seta, nominato dall’IMS president del Congresso di Roma (ancora un riconoscimento ad una personalità italiana, dopo la nomina di Federico Celestini alla direzione della rivista IMS Acta Musicologica: però in quest’ultimo caso si tratta di un cervello fuggito, visto che insegna in Austria come professore ordinario). Tutti noi sentiamo di vivere un’epoca in rapida evoluzione che siamo abituati ormai a considerare ovunque “multiculturale”. I problemi di identità sono spesso legati a conflitti di vario tipo, ma esistono anche aspetti interessanti e positivi, che stanno arricchendo enormemente il nostro modo di fare arte o di concepirla. Eppure in campo musicale questi aspetti non sono mai stati affrontati in maniera sistematica, lasciando agli etnomusicologi il compito di occuparsi di queste nuove frontiere: scelta che rischia di lasciare fuori da questo dibattito una grande fetta del patrimonio della musica mondiale, la musica di tradizione scritta (che si consideri “d’arte” o meno). Ai partecipanti al convegno sono state poste esplicitamente due domande: “come ha operato o continua ad operare la musica in quanto mezzo di costruzione di diverse forme di identità culturale?” e “può la musica contribuire a costruire forme più ampie ed inclusive di identità, promuovendo comprensione e dialogo tra le culture?”. La risposta è stata davvero straordinaria: il comitato scientifico composto da studiosi di tutto il mondo esperti di varie discipline ha selezionato oltre una ventina tra Round Tables e Study Sessions (ciascuna con diversi partecipanti) e circa 360 free papers: ma le domande erano quasi il doppio. Inoltre questa volta più che mai in passato la partecipazione è davvero planetaria, con colleghi che partecipano anche da quelle che erano considerate “periferie” del mondo musicologico, come i paesi dell’est europeo, centro e sud America, molte presenze dall’Asia, ma purtroppo ancora pochi dall’Africa e Medio Oriente. L’allargamento a queste aree è stato una geniale intuizione del mio illustre predecessore come presidente IMS, Tilman Seebass, e sarà anche il mio impegno per i prossimi anni, soprattutto per le parti del mondo finora assenti o quasi: per rendere davvero “internazionale” la società dei musicologi. E’ la seconda volta che l’Italia ospita un convegno dell’IMS dopo l’esperienza del 1987 a Bologna. Cos’è cambiato da allora? A Bologna 1987 siamo arrivati con l’entusiasmo e la meraviglia della scoperta di come in tutto il mondo si considerasse la musicologia italiana un fenomeno importante. Numericamente eravamo terzi dopo Usa e Germania, ma poi gradualmente il numero dei soci italiani IMS è sceso progressivamente, man mano che l’Italia perdeva sempre più una reale rappresentatività internazionale. Le nostre scuole restano tra le migliori del mondo e, oltre a quasi una cinquantina di “emigrati” che insegnano in università prestigiose straniere, contiamo decine di musicologi di grande valore, stimati ma non più conosciuti come un tempo all’estero anche per un atteggiamento troppo limitativo (e direi autolesionistico) di stampare esclusivamente in italiano i risultati delle proprie ricerche, con l’effetto che poi non si è letti dalla massa dei potenziali lettori interessati (pur avendo una editoria specializzata di impressionante livello). I docenti universitari sono troppo presi da una implacabile massa di burocrazia che sta ormai investendo anche i loro colleghi dei conservatori in una emulazione perversa. E sappiamo quanto lo stato italiano abbia investito negli ultimi decenni nella ricerca… Arriviamo dunque al convegno di Roma con un forte gap da superare, ma avverto l’entusiasmo generale che questo evento sta generando. Siamo tutti certi che avremo uno scossone di orgoglio nel presentarci ai colleghi di tutto il mondo nella nostra seconda occasione in cento anni. Nella musicologia italiana che rapporto esiste tra l’università e i conservatori, alla luce soprattutto della nuova organizzazione dei corsi che ha riconosciuto ai conservatori le lauree triennali e biennali? Come accennavo, con la riforma i conservatori italiani hanno rischiato di copiare in maniera perversa soprattutto i lati “pesanti” della organizzazione universitaria, sacrificando la propria specificità di scuole tecniche poco assimilabili ai percorsi umanistici delle facoltà cugine. Ci sono stati anche episodi di aperta ostilità in passato, causati dal solito problema della riduzione progressiva dei posti di lavoro per i primi laureati o diplomati rispetto ad un possibile titolo di pari valore. Oggi per fortuna, pur piombati in una fase di estrema difficoltà per entrambi, si colgono dei segnali di inversione di tendenza estremamente positivi. Per esempio il Ministero della ricerca e università ha da tempo avviato un tavolo tecnico di confronto tra CUN (università) e CNAM (alta formazione di accademie e conservatori) e nel mese di gennaio 2012 ha affiancato a questo tavolo un ulteriore gruppo di tre esperti, presieduto da Franco Piperno (Università La Sapienza di Roma) con Lorenzo Bianconi (Università di Bologna) e del quale faccio parte come docente in ruolo al Conservatorio di Bari e contemporaneamente a contratto presso la Università della Basilicata. Questo gruppo stabilirà la possibilità di una equiparazione reale dei titoli tra università e conservatori a partire dai settori in cui esiste la musicologia. Dunque una prospettiva molto concreta. In base alla sua esperienza internazionale, i conservatori italiani le sembrano pronti per promuovere dei veri programmi di ricerca in ambito musicologico? Nella gran parte dei paesi occidentali e negli Stati Uniti solo l’università è abilitata a rilasciare titoli di istruzione superiore anche in campo musicale e musicologica, essendo i conservatori delle strutture di formazione iniziale o intermedia. Questo ha da sempre causato un problema di immagine per gli italiani che si presentavano in quei paesi come affiliati a conservatori e non università, anche se poi quel che conta per la musicologia internazionale è solo quanto vale uno studioso, verificabile attraverso la qualità delle sue pubblicazioni. Noi siamo ancora legati al modello della Spagna oppure dei paesi dell’Est (dove esistono le accademie di musica), ma anche in quelle nazioni la situazione è in rapida evoluzione. Direi che se i titoli di studio possono già oggi essere considerati analoghi (parlo del I livello ormai ordinamentale, per gli altri esistono maggiori problemi), non dovrebbero esserci problemi a considerare i conservatori pronti per affrontare il delicato problema della ricerca, che è uno dei tre principi basilari nella costituzione del conservatorio riformato insieme a didattica e produzione, ma che non è mai stato realmente attivato. Io stesso per esempio, al Conservatorio di Bari, ho dovuto chiedere con fermezza di poter usare le ore che mi spettano di diritto per fare ricerca, poiché come quasi ovunque il Consiglio Accademico aveva deciso di far utilizzare il monteore quasi esclusivamente per la didattica. Ma ovviamente fare davvero ricerca in un conservatorio dovrebbe implicare il potenziamento delle biblioteche, quasi ovunque abbandonate e senza fondi, e la creazione di laboratori di tipo scientifico. Insomma sembra ancora fantascienza in istituzioni che in parte seguono tuttora programmi emanati con Regio Decreto nel 1928… A giudicare dalle pubblicazioni recenti, la maggior parte dei musicologi occidentali ancora oggi non riescono a spingersi oltre la fine dell’Ottocento, e in ambito italiano non si va al di là del teatro d’opera. Ritiene che si possa cogliere una differenza tra la minoranza che oggi si occupa di Novecento o di contemporaneità e gli altri musicologi “storici”? Nel mondo sta avvenendo in realtà il contrario: sempre meno musicologi sono invogliati a specializzarsi nelle musiche più antiche, avendo le università scelto di inseguire le propensioni giovanili per generi come il jazz, il pop, il rock. Un mio collega esperto di liuto rinascimentale italiano, Victor Coelho, è diventato un idolo degli studenti della Boston University con i corsi e anche le lezioni di chitarra elettrica ed è oggi una vera pop star. Ma basta dare una occhiata ai programmi offerti ovunque e in fondo anche a molte proposte arrivate al convegno di Roma. Nelle università italiane poi si sono chiuse molte cattedre che una volta erano ricoperte da esperti di musica pre-ottocentesca e non sono state rimpiazzate oppure si sono scelti professori a contratto di richiamo “popolare”. Ma ovviamente questo non significa che tra queste materie giovaniliste vi sia la musica del Novecento o la musica contemporanea “colta”. Questa sofferenza delle post-avanguardie del secolo scorso è purtroppo intrinseca alle scelte elitarie che erano state imposte dagli stessi protagonisti e poi avallate per contrasto dai direttori artistici, preoccupati che le musiche troppo “moderne” potessero scoraggiare il pubblico dalla frequenza dei concerti. Di questi problemi si è occupato egregiamente Alex Ross e i lettori italiani ne sono ormai abbastanza edotti. Non posso tuttavia negare che una forte tendenza dei più influenti docenti italiani, e dei loro più affezionati allievi, a persistere quasi esclusivamente nelle ricerche sul teatro d’opera nazionale sia evidente. Credo ovviamente che non ci sia niente di male (facile dire che della musica giapponese dell’XI secolo meglio si occupino i giapponesi…) ma vi sono anche ragioni, diciamo cosi, esterne: negli ultimi decenni tutti i grandi e medi teatri italiani hanno cominciato ad invitare veri studiosi a scrivere nei programmi di sala (compito in precedenza riservato ai critici dei giornali) e in molti casi i docenti proponevano i loro giovani allievi, in modo da farsi le ossa e anche qualche piccolo guadagno. Spero davvero che nella mancanza totale di offerte lavorative queste piccole occasioni restino aperte per i più giovani, magari però intensificando anche la programmazione di musiche dal Novecento in poi, certo.
Lunedì 27 febbraio 2012
|