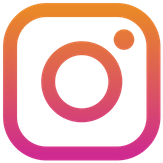In
questi anni ho dedicato al Fagotto un lungo lavoro personale di studio
ed esplorazione. I primi esiti di questo lavoro consistono nella parte
solistica in Mani. Long (2001) per Ensemble, alcuni Studi da concerto (2003), Legno. Edre I-V (2003-04) per Fagotto solo, Legno. Stele (2004) per due Fagotti solisti e Ensemble.
§
Legno Edre I-V (2003-04)
per Fagotto solo è un lavoro di ampio respiro (78') dove interesse
tecnico, pensiero compositivo, concezioni astratte e una sorgiva
emozione verso il suono si incontrano nel punto dove diventa possibile
una particolare “libertà”: quella che nasce quando una totale
familiarità con lo strumento viene orientata dalla attenzione e dalla
capacità di ascolto.
Il suono tradizionale qui non è più il centro. Il fagotto si apre
completamente offrendo tutta l`inesplorata disomogeneità delle proprie
caratteristiche fisiche e acustiche. Quindi espressioni come “ricerca
sul suono”, “ricerca timbrica”, “effetto” ecc. (che si riferiscono
sempre al ruolo evidente o nascosto del suono tradizionale) in questo
caso sono prive di senso. Lo strumento viene ripensato interamente sotto
la spinta di una diversa concezione musicale che pone le proprie
gerarchie e i propri orizzonti - inevitabilmente tutta la tecnica
strumentale muta, e soprattutto il rapporto combinato mani-bocca (e il
sistema di notazione relativo). All’interprete è affidato il difficile
compito di inoltrarsi in questo spazio aperto.
Metrio (2004)
In alcuni studi preparatori ho utilizzato frammenti di particolari
improvvisazioni vocali, che hanno un chiaro influsso di tecniche vocali e
strumentali greche e mediorientali (Mirologhi 1 – 1978, Demetrio
Stratos). Inizialmente ho cercato di imitare e riprodurre questi
modelli proprio perché la loro natura è estremamente lontana dal mondo
tecnico e articolatorio del fagotto.
Un lavoro lento, spesso impossibile, con la consapevolezza però che ogni
stadio di questo lavoro doveva essere contemporaneamente una scoperta
tecnica e la inevitabile apertura di uno spazio: nello strumento e nella
mia attenzione.
In altri studi ho sviluppato delle tecniche in grado di produrre onde
di suono instabili e in costante trasformazione, senza tracce
riconoscibili di una articolazione “umana” (mano-bocca), alcune di
queste sono vere e proprie vibrazioni meccaniche, fenomeno piuttosto
eccezionale per la natura del legno.
Connesse a queste due polarità iniziali sono cresciute costellazioni
di stati e vibrazioni dove invece il più piccolo dettaglio del suono e
delle trasformazioni diventano materia, per una attenzione che cerca e
rende udibile un “interno“ del suono.
Attraverso il lavoro qualcosa prende corpo, si concentra in una forma
plastica, fissa una misura, diventa un nodo di legami. Ogni apparizione
è un ́apertura della materia. Ogni stazione del movimento è anche il
“passo” di una trasformazione. Questa Forma non ha bisogno e non vuole
alcun nome.
Ad un primo ascolto si potrebbe pensare che si tratti di una certa
“libertà” senza struttura (quella “libertà” di secondo grado che
normalmente si ascrive alla improvvisazione...). Forse è un bene che
sembri così.
Il mio ringraziamento e la mia ammirazione a Lorelei Dowling, cui il pezzo è dedicato.
Pierluigi Billone: dal suo sito
 CHI SIAMO
CHI SIAMO
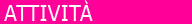 ATTIVITA'
ATTIVITA'
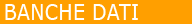 BANCHE DATI
BANCHE DATI
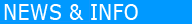 NEWS & INFO
NEWS & INFO
 COMMUNITY
COMMUNITY